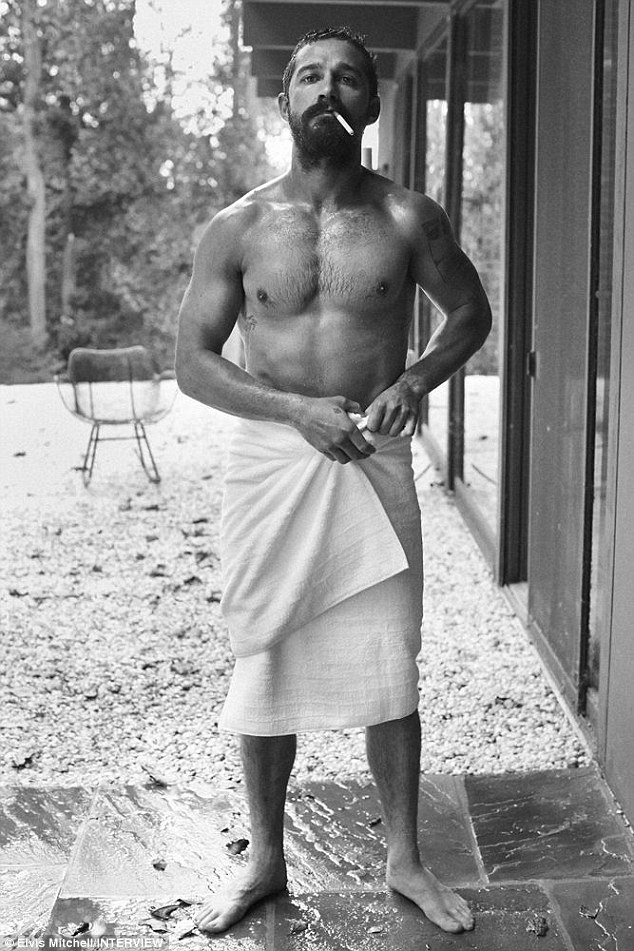Intervista a Mirko Locatelli, fondatore dell’etichetta cinematografica indipendente “Officina Film”
Fondatore dell’etichetta cinematografica indipendente “Officina Film”, sceglie la tortuosa strada dell’antiprotezionismo per poter godere della libertà artistica che in questo settore difficilmente è ottenibile. Dall’amore per il cinema a quello per i temi sociali scavalcati dalle pellicole cari alla convenzione italiana: Mirko Locatelli.
Cinematograficamente quando si parla di “indipendente” il parallelismo con “impegno” è immediato; lo stereotipo è quello di un cinema costellato di gente che ama sentirsi intellettuale crogiolandosi nella bistrattata condizione di anatroccolo nero. Cosa vuol dire realmente fare del lavoro artistico da indipendente e quali sono i cardini della scelta verso questa direzione?
Essere indipendente a mio avviso significa semplicemente essere libero di scegliere cosa inquadrare e per quanto tempo, e per un regista non è cosa da poco.
Libertà nella scelta dei temi e nel modo di trattarli, indipendente non significa necessariamente povero di mezzi anche se nel nostro Paese di solito le due cose a malincuore coincidono, forse perché la libertà di esprimersi degli autori spaventa un po’, c’è quindi la tendenza a dirigere, incasellare, ammaestrare anche chi dovrebbe invece potersi esprimere liberamente.
Quasi tutto il tuo impegno cinematografico si è focalizzato sul tema dell’emarginazione e dell’accettazione propria ed altrui. C’è ancora bisogno di documentare qualcosa che fino a poco tempo fa si dava per assodato o comunque per socialmente superato?
Se certe cose fossero davvero “socialmente superate” non avremmo bisogno di lottare per far rispettare la Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità, o ad esempio nessuno metterebbe in discussione i matrimoni tra persone dello stesso seso o ancora non ci sarebbero episodi di intolleranza così decisi nei confronti degli immigrati.
E’ da queste forme di esclusione che ha origine l’emarginazione che poi riguarda tutti, anche chi non rispetta l’altro, anche chi è responsabile di questo stato di cose ma che un giorno potrebbe ritrovarsi tra gli esclusi e provare l’emarginazione sulla propria pelle.
Hai voluto rappresentare i ragazzi paraplegici non come eroi o vittime del destino e celebri i personaggi distaccandoli dalla loro “difformità”. Ma l’essere “differente” rispetto alla maggioranza della comunità non porta per forza di cose ad un evoluzione almeno in parte atipica e quindi ad una “diversità di fatto”?
Racconto storie di donne e uomini prima di tutto, mi interesso alle loro vite perché sono tutte differenti, se scavi un po’ e vai oltre la disabilità o l’orientamento sessuale, per fare due esempi, trovi dell’altro: o meglio, gli approcci alla vita e le motivazioni che inducono le persone a scegliere che tipo di vita condurre sono tutti atipici e unici, quello che cerco io però non sono evoluzioni atipiche ma interessanti.

Hai dichiarato che “la conoscenza unisce” ma credi davvero che l’anello irreperibile per il quieto vivere sia conoscere realtà diverse dalla propria, oppure forse ciò che manca è il provare a stare l’uno accanto all’altro, magari tramite un processo di immedesimazione, per sentirsi e fare sentire meno soli?
Sono d’accordo anche perché il cinema è uno dei migliori strumenti per favorire l’immedesimazione, non credi?
In Italia alcuni film vengono mediaticamente imposti alle masse. Ottengono incassi e cieca ammirazione grazie al solito, rassicurante e nostalgico frappé di antichi sentimenti prestampati e considerati a priori arte e genialità all’ennesima potenza. Perché gli italiani vanno matti per il macero artistico?
Proprio in questi giorni pensavo che per i produttori e i distributori italiani gli spettatori sono sempre più “aspettatori”, ai quali bisogna dare esattamente ciò che si aspettano, niente di più e niente di meno.
Bertoli diceva: “…e ora dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso e fare il deficiente nei concerti”.
Non è mortificante solo per gli autori, lo è per tutti, per il pubblico, per la società, per chi crede nell’arte come strumento fondamentale ad operare cambiamenti.
Proclami spesso la tua avversione per il preconcetto che il forte ed il bello debba risultare sempre vincete mentre il perdente debba essere necessariamente il debole ed il brutto di turno. Questo concetto di “kalokagathia” (bello e buono) che convinceva parecchio sin dalla cultura greca perché oggi risulta poco raccomandabile e forviante?
Forse è solo perché ho un’idea di bello troppo personale, in ogni caso lo trovo piuttosto discriminatorio come concetto, quindi inadatto ad essere sostenuto sia nella vita tanto meno nei miei film.
Antonio P.